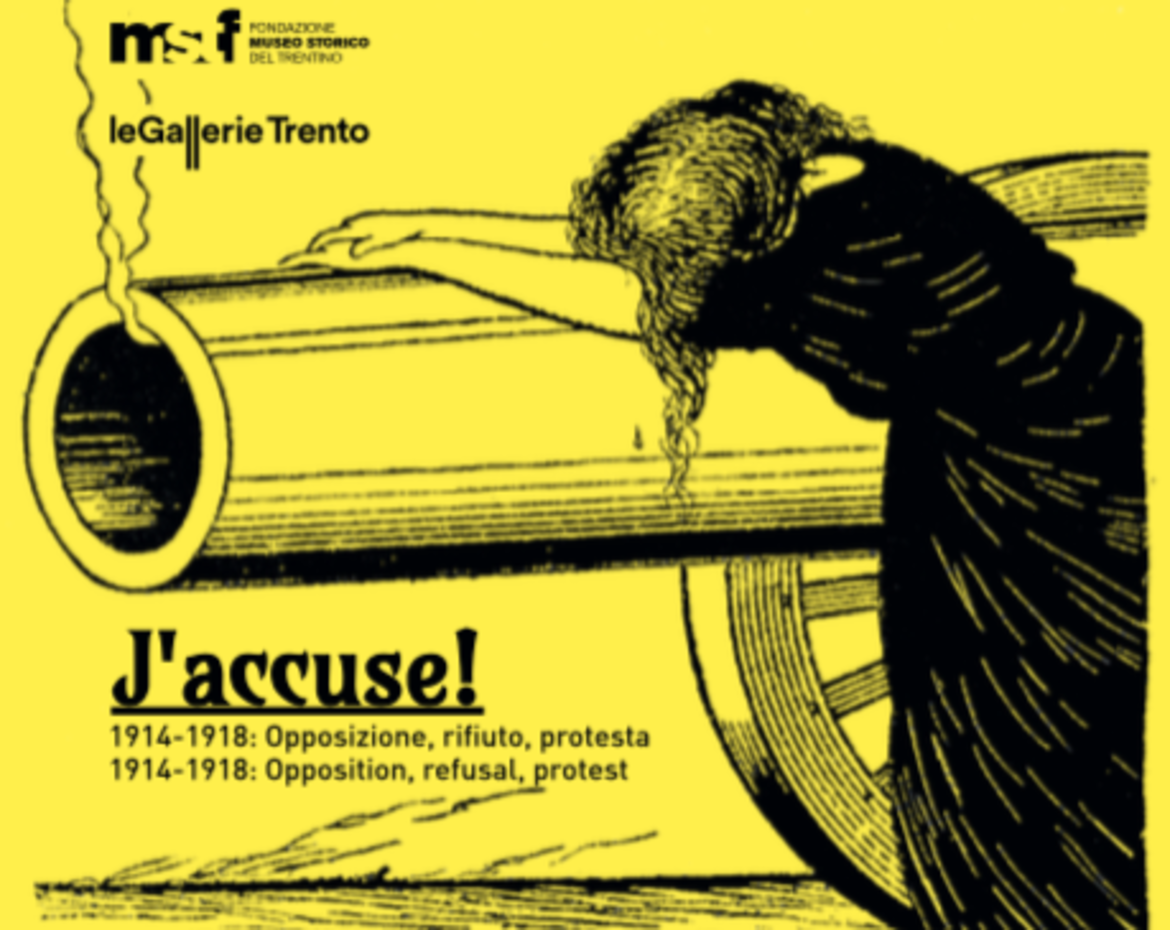
Articolato in cinque sezioni, il convegno – curato da Quinto Antonelli, Bruna Bianchi, Giovanna Procacci, Mirko Saltori – prende le mosse dal dramma del socialismo europeo e dal fallimento del suo ideale progetto di internazionalismo e individua i socialismi che, al contrario, non assecondarono la logica dell’«unione sacra» per la nazione, esi opposero in forme diverse sia all'entrata in guerra, sia successivamente ai montanti nazionalismi. Si segnalano due approfondimenti: uno sul movimento anarchico internazionale, l'altro sulle caratteristiche della rivoluzione che condurrà la Russia ad una pace separata.
Lo scoppio del conflitto nell'agosto del 1914 mise in crisi, fino alla disgregazione, anche la rete organizzativa delle vecchie «società per la pace», ma vide, nel contempo, la rinascita di un pacifismo più radicale che si inventò nuove forme di comunicazione, capace di rivelare il vero volto di un conflitto che colpiva deliberatamente la popolazione civile, di affermare l’incompatibilità tra guerra e cristianesimo, tra militarismo e dignità delle donne, e di mantenere i legami al di là delle barriere nazionali. In questo nuovo contesto, particolarmente incisive furono le prese di posizioni e le azioni di protesta delle organizzazioni femministe e quelle di intellettuali di statura europea come Romain Rolland e Bertrand Russel.
Altro tema centrale affrontato dal convegno è quello relativo al ruolo delle confessioni religiose e delle loro affermazioni teologiche, a partire dalla dottrina della guerra giusta, riaffermata dalla gerarchia cattolica. Sul fronte opposto si mettono in luce le storiche chiese «di pace» (i mennoniti, i quaccheri…), pressoché le uniche a professare la resistenza alla guerra in sé. Lo sguardo si allarga poi anche alle religioni non cristiane, alle chiese ortodosse che furono un importante sostegno agli stati in guerra e al ruolo dell'islam, analizzato qui come fattore determinante del genocidio armeno.
La quarta sessione prende in considerazione la neutralità degli stati e quella delle grandi organizzazioni umanitarie come la Croce rossa, alla quale è dedicata una relazione. Sarà indagato, in particolare sia il caso della Svizzera rappresentata nel corso del Novecento, con una sovrapposizione di mito e realtà, come «il paese accogliente», sia quello degli Stati Uniti, neutrali fino alla primavera del 1917.
Il convegno infine si conclude allargando la prospettiva alle proteste, dimostrazioni e agitazioni, spesso non organizzate, delle masse popolari. A partire dal 1917, agitazioni e scioperi interessarono gran parte delle nazioni in conflitto, dove donne e lavoratori protestavano contro le sempre più difficili condizioni di vita, ma anche, sull'esempio della Russia, per chiedere una rapida conclusione del conflitto. Si segnala un breve focus sulle proteste delle donne trentine particolarmente attive fin dalla primavera del 1915.
Il convegno è rivolto al pubblico più vario che partecipa agli appuntamenti del Centenario, alle associazioni e ai tanti cittadini sensibili ai temi della pace e, naturalmente, agli addetti ai lavori, dagli insegnanti ai ricercatori di storia. A tutti intende mostrare come sia doveroso studiare e scrivere anche una storia della pace e dei pacifici, oltre a quella della guerra e dei guerrieri.
Si segnala infine che, venerdì 17 novembre alle 18.30, alla fine della terza sessione del convegno, la compagnia Indigena Teatro, diretta dal regista Stefano Scandaletti, proporrà il dramma in un atto di Marion Craig Wentworth Spose di guerra (War brides). Quest'opera teatrale, fu rappresentata per la prima volta nel 1915 a New York ed entusiasmò migliaia di spettatori. Tradotto in italiano e pubblicato dalla casa editrice Il Martello di New York (e ora ripubblicato dalla Fondazione Museo storico del Trentino nella collana “Passati presenti”), divenne un classico del pacifismo femminista.










