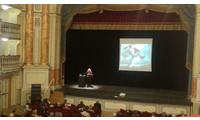Introdotto dallo storico trentino Marcello Bonazza, Gentile ha realizzato un interessante excursus all'interno delle espressioni artistiche che hanno prima invocato, poi accompagnato la Prima Guerra mondiale con il loro armamentario di quell'enfasi comunicativa tipica degli intellettuali interventisti dell'epoca. Ma – ha spiegato Gentile – non si trattava di un fenomeno legato ai soli futuristi più esaltati, basti pensare ad un noto passo di Thomas Mann nel quale il romanziere tedesco definisce gli anni della Belle Epoque "verminosi" e corrotti, auspicando una guerra purificatrice. Gentile si è dunque chiesto il perché di questo sentimento diffuso fra gli intellettuali, del perché, insomma, la guerra fosse diventata un mito di tanti giovani artisti, l'unico evento che potesse mettere fine ad un'epoca, secondo loro, ormai incancrenita e riversata su sé stessa.
La guerra "invocata" iniziò molto prima dell'evento bellico, anticipandone le istanze al primo decennio del '900. Un evento dipinto in modo quasi mistico, così come il mito del condottiero che ha sempre avuto vasta eco nell'attività degli artisti, dai tempi della guerra di Troia alle rappresentazioni romane (pensiamo all'arco di Traiano), all'arte di Paolo Uccello o Piero della Francesca, fino alle guerre continentali di Napoleone e i dipinti dei pittori di corte. Nell'800 si rafforzò il concetto di guerra quale rappresentazione dell'eroismo, sottolineandone gli aspetti epici e sacrificando nella narrativa i morti fra i soldati e i civili. Ma non c'era solo esaltazione della guerra; Francisco Goya utilizzò l'arte quale rappresentazione delle violenze e delle crudeltà delle guerre. Nel complesso, però, l'arte raccontò la guerra come un elemento positivo, di rigenerazione, eroismo, tensione morale. Poi, nel periodo dal 1870 al primo decennio del '900, questo soggetto scomparve dalle rappresentazioni degli artisti, parallelamente al lungo periodo di pace vissuto dall'Europa.
Nel 1911, però, ritornarono in auge i dipinti di guerra, con nuovi stili fra i quali spiccavano quelli di avanguardia che anticipavano, attraverso il futurismo, i venti di guerra, comunque sempre presenti in filigrana in tutti questi anni. Colpisce a proposito un articolo del Corriere della Sera del 1911 citato da Gentile che anticipa con incredibile precisione le distruzioni della prossima guerra, in anni in cui però ancora si parlava di Belle Epoque. "Gli artisti – ha spiegato Gentile – hanno antenne sensibili e capiscono in anticipo che quella civiltà, quell'epoca storica è al capolinea e utilizzano lo strumento artistico per anticiparne il messaggio. Non solo i "nostri" futuristi, ma anche i russi, gli irlandesi, che parlavano apertamente di un'Apocalisse imminente".
Ci fu insomma la voglia e l'esaltazione dell'idea di guerra e poi, quando scoppiò, l'attesa di vederne gli effetti, anche se va detto che in molte opere qualche preoccupazione iniziava a serpeggiare e venivano evocati scenari cupi di partenze, di distruzioni, di vedove vestite di nero. Eppure, il fascino del conflitto sugli intellettuali fu irresistibile. Molti di quegli artisti, infatti, partirono volontari per il fronte, per vedere come era "dal vivo" quell'evento tanto anelato. Tanti vi morirono, altri tornarono a casa sconvolti da quello che avevano veduto. E per tanti mesi, invocato.
-